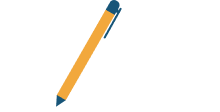Dossier. I verbi del Giubileo (3): RESTITUIRE
Questo dossier è il terzo di una serie di quattro che abbiamo scelto di dedicare ai verbi del Giubileo. Ci accompagna in questo itinerario don Gianluca Zurra, presbitero della diocesi di Alba, docente di teologia presso la facoltà teologica di Torino e l'ISSR di Fossano (CN).
Il Giubileo, nella sua accezione biblica, è un tempo di ritorno al primato di Dio come condizione per ricreare giuste relazioni tra gli umani. Il gesto del riposo della terra e della redistribuzione delle proprietà come freno al consumo predatorio e all’indigenza crescente nascono dalla consapevolezza che nessuno è padrone autoreferenziale della vita, ma dovrebbe esserne un saggio custode a favore di tutti.
Restituire con giustizia, dunque, è molto di più di un dovere normato da un comandamento, poiché si rivela come azione in grado di onorare la radicale differenza tra idolo e Dio: il primo chiede sacrale adorazione a scapito della prossimità con gli altri, mortificando la socialità, mentre il secondo apre lo spazio per la giusta e responsabile fraternità come verità piena della relazione spirituale con Lui.
Vivere il Giubileo, in questo senso, è impossibile senza mettere in campo coraggiosi cambiamenti di stile circa la vita comune, in grado di incidere a livello istituzionale, politico ed economico a proposito della giustizia sociale. Non si tratta di una semplice conseguenza della fede, ma è la condizione tramite cui sperimentare corporalmente l’apertura credente a Dio come compimento della libertà umana.
“Restituire”, gesto profetico
A restituire si impara, fin da piccoli. Sono almeno tre i miracoli della nostra infanzia: riuscire a camminare in modo eretto, pronunciare le prime parole per comunicare in modo consapevole, riuscire per la prima volta a non tenere tutto per noi ma a condividere qualcosa con altri. Quest’ultimo passaggio chiede uno sforzo enorme, più grande di ogni allenamento, da proseguire con perseveranza lungo un’intera esistenza. Quando un giorno la nostra piccola mano si aprì e, piangendo, “restituì” qualcosa ad altri senza sequestrarlo, in quel momento si inaugurò per noi l’avventura umana del confronto con gli altri, della libera solidarietà, in grado di portarci ben oltre il puro istinto della sopravvivenza, per farci entrare nell’universo della gratuità e della reciproca giustizia.
Imparare l’arte della restituzione significa riconoscere che il bene non è riducibile al ben-essere utilitaristico, o allo star-bene con sé stessi, per quanto vi siano implicati, poiché non raggiungerebbe la sua qualità relazionale. Rinunciare a trattenere tutto non è soltanto donare qualcosa per galateo o buon costume, ma significa restituire ciò che da sempre, in noi, è destinato ad essere condiviso con altri. Restituzione, così, fa rima con nascita, con fecondità, perché è un processo di trasmissione vitale, sostenuto dalla passione verso una giustizia per la quale nessuno di noi è pienamente umano e felice senza il coinvolgimento con la possibile felicità degli altri a cui decidiamo di contribuire.
“Restituire” è un verbo bellissimo, al tempo stesso assai impegnativo. Ci apre e ci “scoperchia” da ogni lato: alle spalle, perché ci ricorda che la vita non è prodotta da noi, ma ci precede ed è ricevuta; accanto, perché ci mette fin dall’inizio in comunicazione con gli altri che vivono con noi; davanti, perché ci sprona a inaugurare la speranza lasciando, restituendo, donando qualcosa per chi verrà. Si tratta di un’esperienza che ci espone, che chiede libera e fiduciosa apertura, rischio generativo e non egoistica tranquillità. In tal senso possiamo dire che ci fa “toccare Dio”, nella misura in cui “tocchiamo” sulla nostra pelle la giustizia di rapporti fraterni che ci chiedono di andare ben al di là del nostro utile o dell’immediato tornaconto. D’altronde, chiunque di noi, a propria volta, può vivere e muoversi perché altri, in passato, non hanno tenuto la vita per sé, ma hanno saputo restituirla in abbondanza. Siamo frutto di molte restituzioni e portiamo frutto accogliendo e restituendo a nostra volta.
Mani che restituiscono
Alla sinagoga di Nazareth Gesù inaugura la sua predicazione rivelandosi come colui che fin da piccolo ha appreso l’arte della restituzione. Non a caso il testo ricorda che in quella località “era cresciuto” (Lc 4, 14-30). Che il Figlio di Dio riconosca la sua missione proclamando un preciso passo di Isaia volto a descrivere la discesa dello Spirito del Signore in rapporto a gesti che donano e restituiscono vita, rivela il senso della sua infanzia. Essere cresciuto nella bottega di un falegname, come sanno bene i suoi concittadini (Mc 6,3), non è un dettaglio: Gesù fu educato tramite una concreta “manualità spirituale” in grado di forgiare qualcosa per altri in maniera artigianale. E, al tempo stesso, essere figlio di Maria di Nazareth significa aver respirato da sua madre la capacità unica di restituire vita lasciandola liberamente crescere, avendo fatto dell’ascolto lo stile di un’intera esistenza, come succede nell’episodio della perdita di Gesù adolescente al tempio di Gerusalemme (Lc 2, 41-52).
La lettura alla sinagoga, dunque, non può essere intesa alla maniera di una visione magica, ma è la forza di un testo che risveglia in Lui ciò che fino a quel momento aveva iniziato a sperimentare nell’ordinario della sua esistenza. Compiere quelle scritture, per Gesù, significa dare corpo alla restituzione grata per un legame con il Padre intuito e imparato tra gli arnesi e i sogni di Giuseppe e tra la profondità e il coraggio di Maria. I poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi non sono riducibili a destinatari esterni dell’annuncio del Regno, ma nella relazione con loro Gesù imparerà il suo essere Figlio nella misura in cui se ne prende cura restituendo giustizia. Proclamare “l’anno di grazia del Signore” coincide con questa responsabile prossimità che genera solidarietà a livello sociale, dando compimento, per altro, alla contestazione dello stesso Isaia a proposito del digiuno: “Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?” (Is 58,6). Potremmo dire che si tratta di una singolare opera di falegnameria, in cui lo Spirito abilita le mani, la mente, il cuore a creare artigianalmente fraternità, tramite il gesto profetico della restituzione.
Gesù, in questo senso, è davvero “figlio del falegname”, perché le sue mani sono piene di ascolto creativo (come quelle di Giuseppe) e le sue parole sono piene di gesti coraggiosi (come quelle di Maria). Nazareth, al contrario, non sa restituire, ma solo scandalizzarsi e respingere. Rimane un grembo chiuso, un luogo infantile, autocentrato, mentre il Figlio di Dio, “passando in mezzo a loro”, rivela la lieta notizia della restituzione e della socialità condivisa come pienezza di umanità.
Un impegno sociale
Nel verbo “restituire” tipico del Giubileo c’è, dunque, molto di più di ciò che si possa immaginare: è all’opera il Vangelo e la sua profezia, a favore di chiunque sia pronto a lavorare insieme per una società più giusta. Sessant’anni fa già la costituzione del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo richiamava due indicazioni fondamentali che non possiamo perdere e che oggi non sono per nulla scontate: la destinazione universale dei beni della terra (n. 69) e la funzione sociale della proprietà privata (n.71), sottolineando come la giustizia e la carità siano i due criteri tramite cui i cristiani sono chiamati ad agire, donando il loro contributo alla socialità comune di cui fanno parte, innanzitutto come cittadini. Nell’anno giubilare, trovare tempi e spazi per formare la coscienza sulla logica della “restituzione” significa contribuire a rinnovare dall’interno le istituzioni e il modo di vivere l’economia, evitando un’azione caritativa ridotta a gesti estemporanei di solidarietà che, per quanto importanti, lascerebbero però intatti i meccanismi iniqui che producono disuguaglianze sociali.
Dalla sana abitudine a restituire, maturata giorno per giorno, può nascere così un modo alternativo di edificare e di formare il nostro vivere, imparando a non essere padroni, ma saggi custodi dei beni destinati a tutti, secondo il desiderio di Dio.
Gianluca Zurra