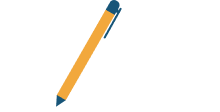Dossier. I verbi del Giubileo (4): CURARE
Questo dossier è il quarto e ultimo della serie che abbiamo scelto di dedicare ai verbi del Giubileo. Ci accompagna in questo itinerario don Gianluca Zurra, presbitero della diocesi di Alba, docente di teologia presso la facoltà teologica di Torino e l'ISSR di Fossano (CN).
L’anno giubilare, insieme alle sue molteplici suggestioni, porta con sé il tema della misericordia. Il Giubileo è sempre un tempo di riconciliazione, un’occasione propizia per attivare pratiche di perdono e di superamento effettivo delle ferite che scaturiscono da violenze e ingiustizie. Un’indicazione sintetica, umanamente rilevante, che può aiutarci a entrare in questa tematica, evitando riduzioni giuridiche o troppo retoriche, è l’esperienza della cura.
Esistiamo perché riceviamo cura
Essere oggetto di cura non si riduce ad un gesto che avviene dopo una ferita o una caduta, poiché è più originario: nel momento in cui veniamo al mondo la nostra vita è sorretta da mani che ci lavano, da cuori che si preoccupano per noi, da seni che ci allattano, da braccia che ci sorreggono, da volti che ci sorridono. Tutto questo ci precede e ci raggiunge ben prima di chiedere aiuto, in modalità diverse e imprevedibili. È la manualità della cura a inaugurare la nostra possibilità di stare al mondo, al punto che quando questo non avviene la nostra esistenza è in pericolo e sentiamo che l’assenza di cura è un’ingiustizia, è qualcosa che non dovrebbe succedere. Curare, certo, vuol dire lenire le ferite, venire incontro a chi è caduto, ma tutto ciò è possibile nella misura in cui facciamo memoria del bene ricevuto, per accoglierlo, farlo nostro e restituirlo in abbondanza. Siamo preceduti dalla cura, esistiamo nella cura, generiamo vita prendendoci cura.
Ringraziare per le cure ricevute e ridonare cura è gesto religioso, poiché ci espone a ciò che sta oltre noi, facendoci approdare alla soglia del bene e non solo dell’utile immediato, alla porta della giustizia e non solo del tornaconto personale. Curare è di per sé un’esperienza debordante, gratuita, una “perdita di tempo” agli occhi di una società commerciale e prestazionale, perché interrompe il profitto e la corsa consumistica. In questo senso possiamo dire che la cura fa entrare l’umano nel “sabato” biblico, nel riposo di Dio che custodisce l’umanità dell’uomo riconducendolo alla sua sorgente, alla sua genesi scaturita da un atto di benedizione incondizionata. Ricordandoci della cura ricevuta e restituendo cura tocchiamo la nostra origine, la promessa degli inizi che sostiene la libertà, le relazioni, la concretezza della nostra storia. Curare è lasciarsi rigenerare nel momento in cui decidiamo liberamente di prenderci cura di altri: risorgiamo aiutando a risorgere, curiamo le nostre ferite versando medicine sulle ferite degli altri e non certo cedendo alla suggestione dell’indifferenza limitandoci alla moda imperante (e imperativa!) della pura esigenza di “stare bene con noi stessi”.
Nella feritoia del gesto medico l’umano ritrova se stesso, uscendo da sé in relazione con gli altri, attivando in questo modo veri e propri processi di ricomposizione dei rapporti, che chiedono tempo, pazienza, capacità di stare a lungo nell’attesa di frutti che non sembrano arrivare. Le chiusure, le violenze subite, le guerre provocano distanze pesanti, ingiustizie insopportabili, spirali di vendetta senza vie di uscita. Solo l’interruzione della cura può invertire il percorso e riumanizzare legami devastati, non limitandosi a raffazzonare in seconda battuta i pezzi dispersi, ma rispondendo alla promessa stessa della vita, che si manifesta a noi così debordante da implicarci in prima persona nell’esercizio responsabile della sua fioritura a favore di chiunque.
Una doppia domanda biblica
La narrazione biblica conosce molto bene questa originaria esperienza umana, nella sua benedizione, ma anche nel dramma e nella responsabilità che comporta. Nel racconto di Genesi Dio cerca Adamo per intrattenersi con lui in una relazione di inedita prossimità. “Adamo dove sei?” (Gn 3, 9) non è la domanda di un investigatore che sta cercando il colpevole di un delitto, ma è l’espressione struggente di chi non può fare a meno del suo amato interlocutore e sarà proprio questa cura divina a smascherare la logica disumanizzante del serpente: all’inizio non sta il peccato, ma la promessa di Dio, che continua a prendersi cura della sua creatura, cucendo vestiti per custodire la fragilità di Adamo e di Eva. Ogni volta che l’umano dimenticherà questo gesto originario tenderà a cadere nella spirale della violenza e a creare distanza dai fratelli e dalle sorelle con cui è chiamato a vivere fin dall’inizio. Caino si sentirà dire: “Dov’è tuo fratello?” (Gn 4, 9). Ancora una volta non si tratta dell’occhio persecutorio di un Dio controllore, ma del cuore divino che sente la ferita del fratricidio, della fraternità drammaticamente interrotta come l’imbocco di una via senza uscita per la sua creazione. Mettendo insieme le due domande emerge l’affresco biblico a proposito della cura: l’umano saprà dove essere e dove stare, senza smarrirsi (“dove sei?”), ogni volta che si prenderà cura dei fratelli e delle sorelle (“dov’è tuo fratello?”). In questa esperienza debordante sta l’umanità dell’uomo, messo in movimento con tutta la sua libertà per attivare sentieri di riconciliazione e di prossimità ritrovata, che non hanno nulla di magico o di automatico, ma che nella difficoltà delle ferite permettono il duro lavoro artigianale del superamento dei conflitti. Nessuna facile pietra da mettere sopra i problemi, dunque, ma coinvolgimento responsabile per ricominciare con giustizia a cicatrizzare le ferite. Da parte di Dio, d’altronde, oltre alle vesti cucite per Adamo e per Eva, ci sarà anche il segno indelebile posto sulla fronte di Caino perché nessuno, nei suoi confronti, moltiplichi la spirale di violenza e di vendetta che porterebbe alla distruzione della creazione.
Sulla strada del samaritano
Il racconto parabolico del “buon samaritano” (Lc 10, 25-37) esprime il modo con cui Gesù attraversa dall’interno la storia umana, lasciando emergere il gesto della cura come origine e fondamento del nostro vivere insieme. Al suo interlocutore che, da buon dottore della Legge, sa benissimo che il cuore delle Scritture è l’inscindibile prossimità di Dio e degli umani tra loro e tuttavia tenta di resistervi, il Figlio di Dio risponde con una parabola che inchioda chiunque alla necessità di coinvolgersi in prima persona nell’imprevisto del fratello che ha bisogno di aiuto. L’esperienza curativa della prossimità non esiste se si imbriglia dentro difese di ruoli, come accade per il levita e il sacerdote lungo la strada. Non si tratta di domandarsi quali condizioni permettano la prossimità, ma come farsi prossimi in prima persona a fronte di ciò che all’improvviso succede. Come si manifesta, qui, un cammino di misericordia e di riconciliazione? Non certo tramite una religiosità sacrale, che finisce per anteporre all’uomo le leggi di purità, ma attraverso un movimento delle viscere (misericordia appunto) in grado di riscattare, prendere sulle spalle, ospitare, risanare quell’uomo mezzo morto. La forza dell’affidamento si realizza così in una forma affettiva, che coinvolge corpo e tempo, ma anche una inaspettata complicità fraterna tra il samaritano e il locandiere che accoglierà il malcapitato per la notte.
Ecco ciò che dovrebbe accadere nello spazio giubilare della cura: una reciproca responsabilità per la tessitura di legami buoni, farmaco per le ferite profonde che tutti ci portiamo dietro e che da soli non saremmo in grado di rielaborare e superare. Curare vuol dire risorgere, anche se non tutto è guaribile. E la cura è talmente originaria in noi che ostinarsi a non voler sentire il suo richiamo non è venir meno ad un galateo alla moda, ma significa perdere la ricchezza e il senso della propria umanità. E non ci saranno ruoli che potranno difenderci, come ritengono, forse, nel loro cuore ormai spento, il levita e il sacerdote della parabola. Come non basterà l’idea mercantile secondo la quale sarebbero alcune pratiche prestabilite a farci “acquistare” il perdono.
Ripartiamo, dunque, dalla cura che abbiamo ricevuto, per restituirla in abbondanza e sarà quello il momento in cui sentiremo sulla nostra pelle l’incondizionato amore non commerciale di Dio e, insieme, la responsabilità coinvolgente che ne consegue per noi verso ogni uomo e donna che incontriamo sul nostro cammino.
Gianluca Zurra